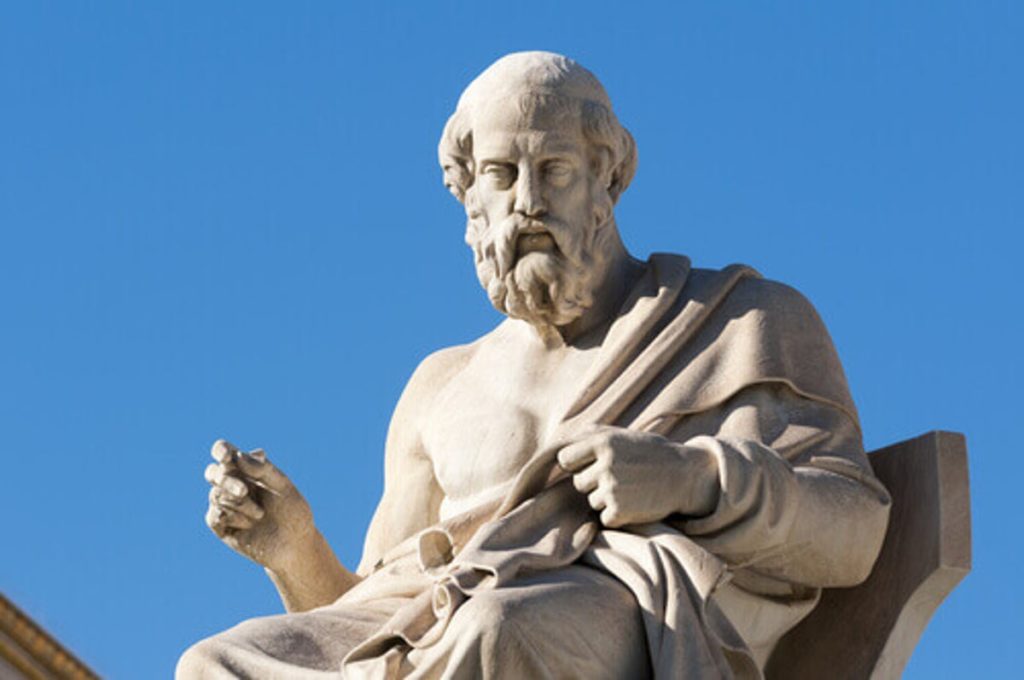
Facciamo un gioco di fanta-letteratura. Immaginiamo che non siano mai esistiti né Shakespeare né Dante né Petrarca. Come sarebbero oggi l’inglese e l’italiano? Malgrado la vastità del suo influsso, senza Shakespeare l’inglese sarebbe più o meno quello che è, dato che il suo sviluppo è stato reso necessario da una serie di condizioni socio-politiche, a cominciare dalla presenza di uno stato centralizzato, di cui la letteratura era solo un tassello abbastanza secondario. Sappiamo bene che all’italiano, invece, un simile supporto sociale e istituzionale è mancato per molto tempo. Se Dante, Petrarca e Boccaccio non fossero mai esistiti, o se fossero nati in Campania o in Veneto, oggi parleremmo un’altra lingua. Perciò, la tentazione di attribuire alla dominanza del petrarchismo pregi e soprattutto difetti della lingua letteraria italiana è forte. Eppure non sono sicuro che questa idea, ripetuta di frequente nel Novecento, sia fondata. A me sembra, al massimo, una verità parziale. Non credo che la “rigidità” dell’italiano rispetto ad altre grandi lingue nazionali dipenda dalla posizione predominante del classicismo di impronta petrarchesca nella nostra letteratura. Le ragioni sono molto più articolate e, in larga parte, di natura extra letteraria.
Sono soprattutto le avanguardie del Novecento ad aver trovato nella linea Petrarca-Leopardi – linea in cui la lirica di impronta classicista viene considerata il vertice della poesia – l’ostacolo da rimuovere per ampliare le possibilità espressive della letteratura. Il modello sempre evocato è Dante, la cui varietà di temi e registri viene vista come l’alternativa salutare alla ristrettezza stilistica e tematica della lirica petrarchesca. Come è ovvio, questo genere di contrapposizioni sono possibili solo creando un’immagine semplificata, se non caricaturale, delle parti in causa. Se si va a leggere Petrarca e Leopardi per esteso, come sanno gli studiosi ma non sempre i lettori comuni, si trova una favolosa varietà di temi, lingue e registri stilistici, in prosa e poesia. Come qualunque altro scrittore, Petrarca e Leopardi sono la totalità delle loro opere, non una parte (una porzione delle poesie) presa per l’intero. E, soprattutto, quei due scrittori non sono i loro emuli, seguaci, continuatori ed epigoni, alcuni geniali, molti mediocri e pessimi, che creano una lente distorsiva per la lettura dei loro stessi modelli. Ma si sa che dal Romanticismo in poi i movimenti letterari hanno creato di volta in volta dei fantocci da abbattere per proporsi come “il nuovo che avanza”. Agli italiani, inoltre, piace dividersi in fazioni opposte e farsi la guerra. Durante il suo soggiorno in Italia, chiesero a Goethe se era del partito di Ariosto o di quello di Tasso, una contrapposizione allora più rilevante di quella fra Dante e Petrarca. Goethe rispose che gli italiani avrebbero dovuto essere orgogliosi e felici di avere due poeti di quella statura invece di perdere tempo a litigare su chi dei due fosse il migliore. Un giudizio che dice molto sulla mentalità tedesca come su quella italiana. Il nostro resta sempre il paese dei Guelfi e dei Ghibellini, dell’appartenenza a un partito, una categoria, una fazione, un clan, una famiglia prima che a una comunità nazionale.
Per quanto possa aver ingabbiato la lingua letteraria nazionale entro limiti stretti, non va dimenticato che con Bembo Petrarca divenne un modello normativo insieme a Boccaccio, la cui lingua non difetta certo di dettaglio empirico e varietà di temi e registri. Insomma, anche senza ricorrere al solito Dante, l’astrattezza e la mancanza di presa sul “reale” non mi sembranodati originari della lingua letteraria italiana. Tanto meno se ricordiamo che a fianco della lingua proposta come nazionale è sempre esistita una produzione letteraria nei dialetti. Se uno guarda il sistema nel suo complesso, la varietà e la flessibilità non mancano, anche se si sono manifestate in modo diverso rispetto a quei paesi in cui una lingua nazionale si è imposta prima che da noi.
L’ovvio dato di fondo che differenzia la condizione italiana rispetto a paesi come la Francia e l’Inghilterra è che l’italiano è stato a lungo una lingua parlata solo in alcune zone ed eventualmente in certe fasce sociali del paese. È il fatto di essere per la maggioranza degli italiani una lingua scritta e non parlata che, a mio parere, ha determinato il carattere dell’italiano, molto più che la dominanza dell’ideale lirico classicista che corre da Petrarca a Leopardi (per altro, la lirica sta al vertice delle estetiche romantiche, mentre in quelle classiciste è un genere minore). Il faticoso lavoro di revisione di Manzoni nelle varie versioni dei Promessi sposi sta lì a dimostrarlo ancora in pieno Ottocento, anche se oggi più di un lettore troverebbe lo stile “espressionista” di Fermo e Lucia e della ventisettana più vivace del nitore neoclassico della quarantana.
Ma a che cosa ci si riferisce quando si parla, come in effetti a volte si fa, della “rigidità” dell’italiano letterario, anche contemporaneo? Il primo aspetto a cui si pensa, soprattutto confrontandolo con altre lingue, è la pesantezza polisillabica. Chiunque si sia cimentato nella traduzione da una lingua straniera ha dovuto fare immediatamente i conti con la misura extra-large dell’italiano, che crea un’infinità di problemi, specialmente quando si traducono poesie in forme chiuse. Ma anche in prosa la lentezza dell’italiano rende spesso difficoltoso trasmettere la velocità e la precisione dell’originale senza ricorrere a forme di compressione e semplificazione, due procedimenti di cui i traduttori italiani devono per forza diventare esperti. In quei frangenti sarà il caso di ricordare che questa caratteristica, la pesantezza polisillabica, è solo in parte originaria dell’italiano. Dante e Petrarca, che a rigore non scrissero né in una lingua nazionale né in un dialetto, furono due grandi abbreviatori. La frequenza di apocopi, elisioni e troncature nei loro testi ci mostra che avevano ben presente il problema, e lo hanno risolto come tutti i parlanti, ovvero tagliando sillabe. Questa procedura caratterizza tutti i dialetti italiani rispetto al latino. Sono gli umanisti del Quattro-Cinquecento, con la loro ossessione per la classicità, che hanno rilatinizzato artificialmente l’italiano, arricchendolo di innumerevoli termini, ma accentuandone il polisillabismo proprio per allontanarlo dai dialetti. Questa tendenza ha toccato nuovi vertici da quando nel secondo dopoguerra l’italiano è diventato la lingua nazionale parlata. Per una sorta di ipercorrettismo antidialettale le elisioni sono andate tendenzialmente sparendo, per cui si vedono sempre più spesso forme come “una altra”, “la avanzata”, ecc. Quando si incappa in queste forme, si ha l’impressione che la lingua sia modellata su una grammatica per le scuole medie, magari per stranieri. Il sapore è quello di una lingua scritta nel senso peggiore del termine, cioè pedantemente scolastica, ammuffita se non mummificata. Per riassumere, ci sono in questa vicenda due altri protagonisti oltre al petrarchismo: gli umanisti, con le loro fissazioni per il latino, e i contemporanei, che per un tic dialettofobico pensano che tendenzialmente non debba esistere nessuna elisione o apocope nell’italiano “corretto” di una persona colta.
Ma che altro può significare che l’italiano è una lingua meno flessibile di altre grandi lingue nazionali europee? Nei registri alti della speculazione astratta l’italiano non sembra meno attrezzato delle altre lingue nazionali. È nei registri medi e bassi, quelli che riproducono e simulano il parlato, che affiorano le difficoltà. Il fatto è che in questo ambito la presenza dei dialetti è ancora determinante. Per dare vivacità e credibilità a una scena ambientata in un luogo e un tempo specifico, specie se in provincia, l’italiano “nazionale”, senza accento, non è sempre la scelta migliore. Le soluzioni sono innumerevoli e dipendono dalla poetica del singolo scrittore, ma l’uso di inserti dialettali o di italiano regionale è una pratica corrente, evidentemente perché molti sentono che un italiano neutro, senza accento, risulterebbe inespressivo, artificiale, poco realistico, poiché tutti sanno che nella vita reale non si parla un ipotetico italiano standard. Da questo punto di vista Verga sembra essere un esempio più seguito di Manzoni.
Vorrei chiarire che questa condizione, specchio della nostra storia linguistica, non è affatto un unicum. È vero che in inglese, lingua nazionale parlata da tutti da mezzo millennio, è più agevole passare dal sublime all’infimo senza troppi scossoni, ma la stratificazione e gli attriti stilistici non sono sconosciuti neppure lì. La vitalità delle letterature anglofone contemporanee deve molto proprio all’uso delle varietà non standard messe in campo dagli autori postcoloniali. Non siamo lontani dal gioco fra lingua nazionale, regionale e dialetto della nostra narrativa. A me pare che la differenza, a prescindere dal talento dei narratori, la faccia non tanto il dialetto e la varietà regionale in gioco, quanto la lingua “maggiore”, che nel caso dell’inglese è la lingua globale, nel caso dell’italiano una lingua nazionale di media taglia. Uno dei problemi è che le traduzioni italiane degli autori postcoloniali in genere non riproducono minimamente il loro complesso gioco linguistico, ma ne appiattiscono lo stile in un traduzionese monolinguistico in cui timidamente si affaccia qua e là qualche regionalismo. Un esempio per tutti è la disastrosa traduzione del più bel poema lungo in inglese apparso negli ultimi decenni, Omeros di Derek Walcott. Non che esista una facile soluzione per questi problemi, beninteso; ma se si decide a priori per motivi commerciali che il plurilinguismo di quegli autori non è riproducibile e che tanto vale usare un italiano medio neutro, non si arriverà mai a una traduzione che ci indichi che cosa succede nell’originale, linguisticamente e quindi culturalmente. La massa sempre crescente di traduzioni dall’inglese, specie di narrativa, pubblicate e lette in Italia suggerisce una medietà stilistica che non esiste negli originali. Ciò, purtroppo, crea un modello di successo a cui molti nostri romanzieri alla ricerca del successo globale tendono ad adeguarsi, magari in modo inconsapevole.
Plurilinguismo e ibridazione, dunque, sono a disposizione di chi vuole la varietà o anche solo una patina di colore locale. È una tradizione consolidata, almeno dai tempi di Pascoli, non certo una pratica provocatoria, tanto che autori come Camilleri l’hanno usata per produrre best-seller. Non per questo dovremo demonizzare il nitore di matrice neoclassica o considerarlo un anticaglia. Ci sono alcuni poeti di valore che hanno provato a rielaborare questa tradizione utilizzando l’italiano così come si è configurato negli ultimi decenni. Penso alle esperienze dei poeti romani legati a “Prato pagano”, da Valerio Magrelli a Claudio Damiani a Roberto Deidier, o a quelle dei padovani di “Scarto minimo”, come Stefano Dal Bianco e Mario Benedetti, senza dimenticare Umberto Fiori, che è approdato a un orizzonte analogo passando per una strada diversa.
Determinati tratti caratteriali della lingua italiana sono indipendenti dalle scelte di poetica. Anche l’italiano è capace di flessibilità e brevità, che non sono date dalla natura monosillabica della lingua, ma vanno cercate tramite la sua capacità idealizzante e astraente. Come esempio si può citare un passo (vv. 8-11) di “To Autumn” di John Keats (1819)
to set budding more,
And still more, later flowers for the bees,
Until they think warm days will never cease,
For Summer has o’er-brimm’d their clammy cells.
tradotto di recente da Deidier (2019)
e ancora, ancora
Fiori tardivi sbocci per le api
Convinte di restare sempre al caldo,
Ché ogni cella d’estate ha traboccato.
Come in mille altri casi, il traduttore italiano ha il problema di comprimere l’originale (specie quando, come in questo caso, si traduce in endecasillabi il pentametro inglese) senza perdere il senso e mantenendo un andamento fluido. Letteralmente quei versi inglesi significano: “per produrre altri germogli, / e altri ancora, fiori tardivi per le api / finché esse pensino che i giorni caldi non finiranno mai, / poiché l’Estate ha fatto traboccare le loro celle appiccicose.” Deidier ha omesso diversi dettagli, recuperandoli in un termine o un giro di frase generalizzante che li contiene. I versi italiani sono privi della minuziosità descrittiva dell’inglese, ma in un certo senso nulla di essenziale manca in quegli endecasillabi. Il verso tradizionale italiano esprime quella cosa in questo modo. Meno dettagli, più sintesi idealizzante. In breve, Deidier ha sfruttato le caratteristiche della lingua italiana invece di remare loro contro. Non è l’unica soluzione possibile.
Lo stesso passo dell’ode di Keats è stato reso da Annalisa Manstretta(2018) in questo modo:
e sbocci fiori su fiori, anche se tardi,
anche se illudi le api di un’estate senza fine
traboccante di miele.
La procedura di compressione è presente anche qui, benché la traduzione sia in versi liberi. L’ultimo verso è perfino più ellittico di quello di Deidier, ma evita la patina neoclassica del “Ché” e dell’inversione. Lo stile di Manstretta si avvicina di più alla scorrevolezza della lingua comune, ma per mirare alla poesia ha sentito comunque la necessità di omettere alcuni dettagli. Un eccesso di dettaglio in italiano allunga i versi annacquandone il ritmo, oltre a recare sempre con sé qualcosa di prosastico. Trasportate in italiano, le “clammy cells” di Keats suonano inverosimili, come dimostrano le versioni che le hanno tenute tali e quali, ad esempio quella di Silvano Sabbadini (1986), che traduce: “perché l’estate ha colmato le loro celle viscose”. Da notare, fra l’altro, che anche in un contesto di resa letterale “haso’er-brimm’d”, “ha fatto traboccare”, è diventato “ha colmato”, per ovvie ragioni di brevità.[1]
Volendo generalizzare, si potrebbe dire che l’italiano è una lingua “platonica”. Mi spiego meglio. Prendiamo una serie di parole come vetro, vetrino, vetrina, vetrinetta, vetrata. Pare quasi che nel bagaglio concettuale dell’italiano esista l’idea di un oggetto base, il vetro, che i suffissi trasformano in una serie di altri oggetti in vetro. Basta il cambio di dimensioni, linguisticamente, a renderli cose diverse, imparentate dal fatto di essere composte di vetro, che ne pare quasi l’essenza. In inglese, cultura con una dimensione empirica e pragmatica più pronunciate, è la funzione a fornire la distinzione linguistica: vetro è glass, vetrina shop window, vetrino slide (che ha diversi significati, per cui fuori contesto si deve specificare microscope slide), vetrinetta cabinet, vetrata glass window o glass door o stained glass(window). È la funzione a definire l’oggetto, mentre il materiale di cui è composto spesso non compare neppure, come si nota. Non essenzialismo ma empirismo. Ogni lingua ha il suo carattere, inutile incaponirsi a cercare la velocità monosillabica e l’abbondanza di dettaglio empirico dove i tratti distintivi sono altri. Certo, con i dialetti italiani la storia è in parte diversa, e questa possibilità è a disposizione degli scrittori che la vogliono percorrere, in proprio e ibridandola con l’italiano e magari altre lingue (come ha fatto ad esempio Giovanni Nadiani).
Per completare quanto detto sopra, ho già discusso altrove come, a mio parere, si sia affacciata nella nostra poesia una generazione di giovani poeti, come la già citata Manstretta e altri, in cui si sente un approccio più naturale verso l’italiano.[2] La naturalezza e la flessibilità non costituiscono più l’obbiettivo di una poetica che in funzione anti sperimentale recuperi il parlato basso della Linea Lombarda o il neoclassicismo, come nel caso dei poeti citati sopra; piuttosto, naturalezza e flessibilità sono il sentimento di fondo verso la lingua da cui muovono questi giovani poeti, che non formano un gruppo articolato attorno a un manifesto, ma provengono da esperienze diverse, legate a mio parere da questo atteggiamento nuovo. La lingua non è più “un problema”, perché si parte da quella che, bella o brutta che sia, è la propria lingua scritta e parlata: l’italiano. Solo muovendo da queste premesse la rigidità di una lingua troppo scritta e scolastica può sciogliersi nella fluidità dell’uso comune, che sarà per la letteratura solo una base di partenza, diversa dai marmi perfetti ma un po’ mortuari del passato.
Premessa necessaria ma non sufficiente, tuttavia. Altre derive incombono sulla poesia, sempre così difficile da raggiungere. Mi è capitato di recente di tradurre in dialetto alcuni poeti italiani contemporanei per un’antologia curata da Marco Bellini e Paola Loreto per RP Libri. È stata un’esperienza interessantissima sotto molti profili. Ho potuto toccare con mano da quella prossimità che solo la traduzione permette quanta distanza resti fra la lingua poetica italiana e il dialetto. Ognuna delle due ha i suoi punti di forza, ma se dovessi indicare un pericolo per la poesia italiana di oggi direi che è l’astrazione. L’intellettualizzazione della scrittura è un dato così acquisito che si tende a scivolarci dentro senza neppure notarlo, credendo che generalizzare attraverso concetti astratti significhi universalizzare. In realtà la poesia, come tutte le arti, funziona in modo opposto: cerca l’universale attraverso il particolare. Individualizza, e nell’individuo emblematico coglie l’universale. Scivolare subito nell’astratto senza averlo colto nel particolare, nell’esperienza specifica di un oggetto, un evento materiale o psicologico, è una scorciatoia ingannevole. L’arte deve descriverci in modo memorabile una sedia, come ha fatto Van Gogh nel suo capolavoro che una volta visto ci si stampa in testa, non imbastire ragionamenti sul sedersi come astrazione concettuale, che si può elaborare meglio in discipline come la meccanica, la fisiologia, la medicina e quant’altro. Credo che a questo riguardo la poesia dialettale abbia ancora qualcosa di importante da mostrare a quella in italiano.
[1] Per un’analisi più dettagliata si veda John Keats, All’autunno, a cura di Edoardo Zuccato, Mucchi, Modena, 2019.
[2] Rimando all’articolo perché non posso ripeterne qui i dettagli: “Chiusa la questione? Riflessioni sulla lingua e la poesia italiana recente”, Versants, 65: 2 (2018), pp. 9-16.
Edoardo Zuccato insegna letteratura inglese alla IULM di Milano. Si è occupato di poesia romantica e contemporanea e di traduzione. Ha tradotto numerosi poeti inglesi, romantici e contemporanei, ed è autore di cinque raccolte di poesia, quattro in dialetto e una in italiano.
